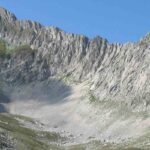Sembrerebbe appartenere alla terra, Roscigno nel Parco Nazionale, ma è paese di acqua.
Sembrerebbe appartenere alla terra, Roscigno nel Parco Nazionale, ma è paese di acqua.
Acqua che si insinua nelle fondamenta, che scava, acqua dei lavatoi e della fontana, acqua che scende dal cielo, copiosa, nei lunghi e rigidi inverni. Nell’Alto Cilento il suo esempio è pressocchè unico. Bisogna camminarci dentro per rendersene davvero conto. Roscigno, quasi 600 metri sul livello del mare, appartiene pervicacemente al Parco Nazionale del Cilento , Vallo di Diano ed Alburni (Sa).
Il borgo si apre a raggiera. Ora che è vuoto ancora risuona di richiami e di grida di bambini anche ora che esibisce le finestre squarciate dal vento, i tetti scoperchiati da chissà quante tramontane, mura pericolanti come bocche di vecchi.
Il nome del paese è una derivazione dalla dizione dialettale “russignuolo”, vale a dire usignolo.
Passeggiando tra quelle sue pietre, ci si accorge che tanta storia è transitata qui dentro.
Ma com’era vissuta la vita in questo borgo? Quali erano i suoi volti? Quali discorsi e interessi si tessevano tra queste mura e nella larga piazza dove son sopravissuti i platani? Come si è costruita la vita tra queste pietre che rimandano a tempi lontani, a botteghe e palazzi austeri o a quando Don Filippo De Saijs, cancelliere archiviario, ultimo erede di una nobile famiglia normanna viveva gli ultimi luccichii dell’era borbonica. Evacuato dal 1902 in poi a causa di due ordinanze del genio civile (la legge speciale n. 301 del 7 luglio 1902 e la legge n. 445 del 9 luglio 1908), il paese si è andato svuotando, obbligando la popolazione al trasferimento nell’attuale ubicazione del paese, Roscigno nuova.
Dietro i portoni sprangati del borgo abbandonato pulsava la vita domestica, uomini e donne alle prese con la quotidianità, immersi in un paese che non era di certo silenzioso come oggi. Festosi e agghindati come meglio potevano, nelle ricorrenze principali, quali San Nicola, San Giovanni, la Festa della Madonna attendevano quei giorni per ingraziarsi la divinità. Dai documenti risulta che nel Natale del 1777 la chiesa dedicata a S.Nicola fu colpita da un incendio, dovuto alle candele, che la danneggiò in modo considerevole. Ora esibisce tutta una struttura sbilenca internamente, ma dal fascino inalterato come quele belle donne che non son capaci di sfiorire con gli anni.
Alla rovina scampò solo l’altare maggiore in un’epoca senza autobotti e Vigili del fuoco. Nel 1700 la maggior ricchezza del paese consisteva “nell’olei, in ghianne, in grano ed in vino ,essendo esso abitato da mille persone e numerato per fuochi 53”. Si racconta anche di un incidente causato dall’acqua, qui dove tutto sembra solo silenzio e vento. “Nel luogo detto Bella Pala vi era una paludetta di circa una misura in semina, ma accaduto un alluvione d’acqua nell’anno 1776, divenne un lago di estenzione di circa misure sei e di profondità immisurabile, tanto che arrischiatovisi a nuotare per vederne il fondo, Francesco Mazzeo, miseramente vi annegò nel mese di Aprile dello stesso anno, e per tutte le diligenze state, non potè rattrovarsi il di lui cadavere se non sovragiunte dopo otto giorni una gran pioggia, già il portò a galla…”
Storie di gente comune e di famiglie nobili che solo in parte conosciamo. Dietro i portoni di queste case vivevano uomini presi a coltivare la terra , che uscivano all’alba con gli attrezzi che cambiavano in base alle stagioni, forche, rastrelli, zappe e donne affaccendate a fare il bucato nel lavatoio pubblico.
Farmacista del borgo don Vincenzo Resciniti che lavorò in paese nella metà del XIX secolo preparando tisane, misture, vendendo sanguisughe e quanto altro poteva lenire i tanti mali di un tempo al quale mancava ancora la penicillina e tanto altro.
Questo vorrebbero raccontare le pietre, le travi e questi balconi dove resiste ancora qualche pianta di geranio. Eppure c’è chi tra gli attuali abitanti di Roscigno sa particolari del paese e li sa raccontare. Ora a narrare quei luoghi sono le pietre, le case , alcune ristrutturate, ma soprattutto i tanti strumenti per il lavoro dei campi e della pastorizia serbati nel locale.
Museo della Civiltà contadina .
Sono forche, aratri, orci, bilance, torchi con macine in pietra, tutti a raccontare quando ci si faceva luce con le candele e le lucerne ad olio e la vita era giocata sull’alternarsi del giorno e della notte e delle stagioni.
/>Mariantonietta Sorrentino